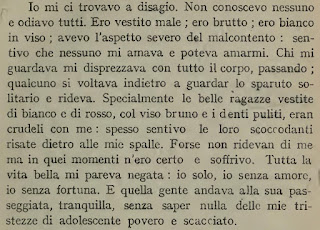Colei che non mi vuol
più bene è morta.
È venuta anche lei
a macchiarmi di pause
dentro.
Chi non mi vuol più
bene è morta.
Mamma, tu sola sei
vera.
E non muori perché
sei sicura.
Questa breve poesia
di Rocco Scotellaro (Tricarico 1923 - Potrici 1953) porta la data del 13 dicembre 1953; fu scritta dal poeta
lucano due giorni prima della sua morte. Entrò quindi nella raccolta postuma
intitolata È fatto giorno che la
Mondadori pubblicò nel 1954. È la seconda delle due liriche che compongono la
sezione Ultime.
Già dal primo verso
si evidenzia una profonda amarezza del poeta che da poco è stato abbandonato
dalla donna amata, proprio nel momento più duro della malattia. La frase
iniziale viene ribadita anche nel quarto verso, come a rimarcare il fatto che
la persona su cui Scotellaro faceva più affidamento, perché pensava provasse
amore nei suoi confronti, ha tradito le sue aspettative. I due versi finali
sono una dichiarazione estrema d'amore nei confronti della madre che è l'unica,
vera persona capace di amarlo fino in
fondo di un amore certo, sincero e infinito. In effetti, penso che la stessa
cosa possa dirsi per quasi tutta l'umanità: al di là delle relazioni amorose
che un individuo può stringere lungo l'arco della sua esistenza, l'unico vero,
grande, ineguagliabile e naturale amore rimane sempre quello materno.